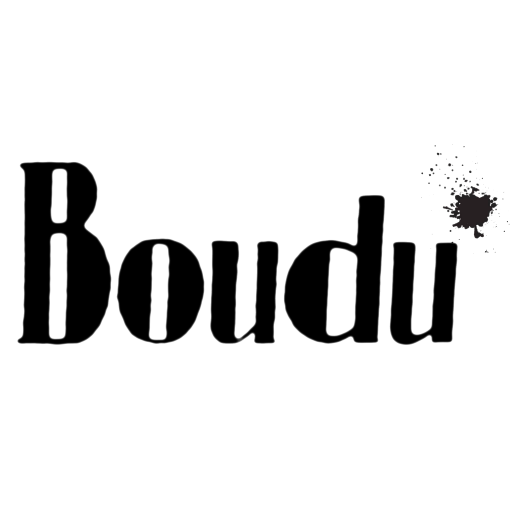di Bruno Roberti
Agli occhi stupefatti dei primi spettatori del cinema si rivelava il mondo spostato su un altro livello di realtà, fatto con la luce e l’ombra. I Lumière le chiamarono “vedute”. Inoltrarsi nel mondo buio della sala dava accesso a una veduta di luce. Appunto una “veduta luminosa”. Come è possibile oggi risalire a questa epifania di luce generata e poi reimmessa nell’ombra, e ancora rigenerata, percorrendo un cammino che riporti il film al suo dato contemplativo? È verso quell’andare che ci conduce Fabrizio Ferraro con il suo nuovo film (presentato alla Berlinale di quest’anno). Significativamente si parte dalla “scomparsa” di un regista che troviamo all’inizio disteso nel buio in attesa che qualcosa si riveli, non tanto la possibilità di un film, quanto l’incamminarsi verso una rivelazione, che è quella del cinema. Di un luogo irrintracciabile se non immergendosi nel suo allontanarsi e trascorrere nel tempo che si disfa. Il tempo dell’andare, del camminare “verso”. Il luogo da raggiungere è quello di Holderlin, della vita abitante di una poesia che si disperde e si smaglia proprio là dove sembra rivelarsi (e su cui il nuovo libro di Giorgio Agamben, La follia di Holderlin, riflette). È come se Ferraro abbia filtrato il suo lavoro radicalmente sulla trasparenza e la compenetrazione dell’«abitare poeticamente il mondo» (per dirla con un filosofo come Heidegger, che proprio dai luoghi holderliniani immaginava nella poesia e nella possibile rigenerazione del divino, a partire dal suo congedo, una salvezza) e insieme abbia, altrettanto radicalmente, aperto varchi a una visione la cui possibilità si dà nella sua stessa impossibilità di esaurirla. Quello che apparentemente potrebbe essere un viaggio di sopralluoghi diventa man mano lo stesso, intimo, senso del film.
È una donna, Catarina, assistente di un produttore, altrettanto “scomparso” che va a cercare il regista, il cui nome emblematico è Mr. Emmer, per affiancarlo nell’attraversamento della Foresta Nera nel viaggio verso Tubinga, che videro gli ultimi 36 anni della “follia” di Holderlin, ospite del falgname Zimmer, in quella casa denominata Torre, affacciata sul Neckar. Quella che per il succedersi regolare del mondo appariva come follia fu una testimonianza estrema del poeta di abitare là dove apparentemente nulla accade, se non il procedere eterno della natura («Non mi succede nulla» ripeteva Holderlin e il suo contemplare il paesaggio dalla finestra è in tal senso significativo), eppure tutto sembra sprigionare ed emanare in un accadimento verso cui l’unico atto possibile è il guardare. Guardare la natura là dove i boschi sacri agli Dei, che sono scomparsi, hanno lasciato una sorta di incavo, di radura, di richiamo alle immagini, al percepibile in quanto tale. Questa forse la ragione per cui Ferraro gira interamente il film usando il colore (di cui solo raramente, come in una parte di SebastianO aveva fatto): dare accesso al puro esistere dell’accadere visibile della natura, nella sua manifestazione, davanti la macchina da presa, condensarne e disfarne la gradazione buio/luce. Tra il regista e la giovane donna ( più che interpretata “vissuta” da Caterina Wallenstein, che proviene dal cinema di De Oliveira e che già Ferraro aveva affiancato al Benjamin del precedente Gli indesiderati di Europa) si dipana una relazione di allontanamento-prossimità.
Mentre Catarina si affida alla possibilità di un senso, di una realizzazione del progetto, Mr. Emmer se ne distanzia sempre di più affidandosi all’andare e al guardare, compulsivamente fumando una sigaretta dietro l’altra, ed enunciando misteriosamente e semplicemente una parola che è insieme di poesia nel momento in cui tende a farsi immagine, e “visione” filosofica, e che si assorbe sempre più in un ostinato silenzio. In qualche modo si viene accordando con quella forma dell’idillio cui, antitragicamente, le estreme poesie holderliniane si affidano. Non si tratta più di dar forma al tragico, quanto di dissolverlo e assolverlo in una forma di conciliazione eterna e naturale, entro cui il dissidio intraveda quel “sorriso degli dèi” consapevole della “commedia del mondo” e insieme della forma-apparizione del naturale. Non a caso nei due “eteronomi” (anche in senso pessoano) Scardanelli e Salvator Rosa, con cui vengono firmati gli ultimi suoi “idilli”, vanno in senso antitragico: da un lato una sorta di “maschera”, dall’altro un pittore di paesaggio che fu anche attore e inventore di una maschera della commedia dell’Arte, il Signor Formica.
Allora il cinema di Ferraro con questo film attinge proprio a tale assolvimento per cui erranza e contemplazione si sciolgono in una messa in campo della stessa pura natura del cinema come immanenza, come accadimento. Una sorta di riflesso del movimento animale. In tal senso il film, diviso in tre parti, si muove da subito, nella sua prima parte (sotto il titolo “Tu nobile bestia”) ambientata in uno zoo, su questo punto di trasparenza e insieme di separazione riflessa. Il regista e Caterina osservano un orso e un gruppo di scimmie che si muovono al di là di un vetro, di una separazione trasparente. È un po’ l’invocazione affinché in qualche modo su questo moto aperto dall’animalità, il film si riveli («le scimmie andrebbero guardate negli occhi giorni e giorni» dice il regista).
Dopo il continuo e incessante movimento animale, c’è sempre un momento in cui giunge urgente una voglia di capire… Durante la lavorazione del film e nei momenti più difficili, ho sempre avuto l’impressione che tutto fosse già fatto. È stato un lavoro molto faticoso, voler significare qualcosa senza significare nulla. Ma poi sorge una domanda. Cosa stiamo facendo, perché tutta questa energia, questo incessante gioco della vita, interno ed esterno al quadro del film, per ritrovarsi in fin dei conti nella sospensione oppositiva del cinema? Anche perché il cinema ed i film raramente vanno insieme, si sospettano vicendevolmente (Ferraro 2021, passim).
È un appello per essere pronti (“Sei pronto?” è la domanda inaugurale del film) a mettersi in cammino, lavandosi lo sguardo, senza sovrapporre immagini o aspettative “verso posti dove incontrare ciò che sparirà”, eppure, riflette ancora Mr.Emmer, “le immagini proliferano e a volte non possiamo rinunciarci”. Inoltrandosi negli anfratti del buio dei camminamenti dello zoo, è come se quel buio dissolvesse la separazione schermica, e il viaggio verso i luoghi holderliniani potesse avere inizio. L’inaugurazione di questo viaggio si enuncia e insieme resta sospesa. Il lavoro, tipico di Ferraro, sulle durate e sul movimento del camminare, dell’inoltrarsi, dell’andare qui incede e da accesso a una dimensione dove, ancora una volta, erranza e contemplazione si embricano, e il farsi del film avviene, con grande densità materica, sotto i nostri occhi, anche sotto gli occhi della natura, dei suoi intrichi boscosi, delle sue radure di luce improvvisa, dei suoi orizzonti silenziosi.
In tal modo il film sosta nella indecidibile aporia tra il realizzare un film e avere accesso al mistero del cinema («né un’arte, né una teoria, ma un mistero» dice Godard). I due, che erano partiti in auto, a un certo punto (dopo uno splendido momento in cui Caterina canta una canzone portoghese) lasciano l’auto, per decisione del regista, e proseguono a piedi. Una sorta di forza di attrazione e inerzia, di ribellione e di rassegnazione, ma al fondo un movimento d’amore, tiene i due immersi nella ricerca di qualcosa che sempre più avanzando si sottrae. Tale nascondimento paradossalmente lascia il posto, di passo in passo, a una rivelazione.
Nel film la sospensione e il “punto di fuga” delle immagini convergono verso: «Quel qualcosa dall’impossibile comprensione: la vita immediata che sfugge mentre si cerca di contenerla. E questa fuga, che canta una concretissima presenza astratta, è proprio un’arte, l’arte della fuga» (ivi). Tutto accade come se l’adesso della macchina da presa, l’apprensione dell’occhio (in camera a cogliere il bagliore che fugge sempre più in là c’è Felice D’Agostino, altro radicale e “non riconciliato” cineasta, in coppia con Arturo Lavorato) si disseminasse nel tempo di una ripresa che avanza verso l’infinito “fuori tempo”, fuori dal film stesso, per cogliere qui ed ora il depositarsi di un cinema ancora possibile in una dimensione altra, nascosta nella vita abitante. «Il tenore di verità di una vita non può essere definito esaurientemente in parola, ma deve in qualche modo restare nascosto. Esso si presenta, piuttosto, come il punto di fuga infinito in cui convergono i molteplici fatti e gli episodi, che sono i soli che sia possibile formulare discorsivamente in una biografia» (Agamben 2021, p. 9). In un tale punto di fuga, nel bianco abbacinante, sfocia La veduta luminosa, mentre il film si allontana dal nostro occhio, facendo balenare il tempo di una vita. La vita del cinema.
Riferimenti bibliografici
G. Agamben, La follia di Holderlin, cronaca di una vita abitante. 1806-1843, Einaudi, Torino 2021.
La veduta luminosa. Regia: Fabrizio Ferraro; sceneggiatura: Fabrizio Ferraro; montaggio: Fabrizio Ferraro; interpreti: Alessandra Carlini, Catarina Wallenstein, Freddy Paul Grunert; produzione: Passepartout, Eddie Saeta, Rai Cinema; origine: Italia/Spagna; anno: 2021; durata: 88′.
Bruno Roberti • fatamorganaweb